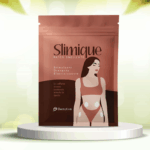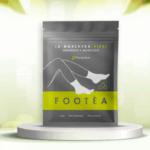Molte delle sostanze che percepiamo attraverso l’olfatto possono rappresentare un rischio concreto per la salute, oltre il mero fastidio soggettivo. Secondo le più recenti ricerche, alcuni odori intensi o persistenti sono “spie” di presenza nell’aria di composti chimici volatili potenzialmente dannosi, in grado di influenzare negativamente il benessere fisico e psicologico delle persone, fino a compromettere la qualità della vita secondo la definizione dell’OMS.
Cosa rende un odore dannoso?
Gli odori sgradevoli sono spesso legati all’emissione di sostanze chimiche volatili (VOC, Volatile Organic Compounds) provenienti da attività industriali, agricole, impianti di smaltimento rifiuti, traffico veicolare, o da comuni prodotti per la pulizia e la profumazione domestica. Non tutti questi composti sono sempre pericolosi, ma alcuni hanno una tossicità documentata sia nel breve che nel lungo termine.
Le scale di rischio variano in base a diversi fattori:
Alcuni odori molesti, oltre al disagio sensoriale diretto, causano “danno alla salute” certificabile, sia attraverso effetti biologici sia per la perdita di benessere e serenità, soprattutto se l’esposizione è cronica.
Composti e odori ad alto rischio
Si possono classificare alcune famiglie di composti odorigeni particolarmente pericolose:
Solfuri e composti solforati
Sostanze come idrogeno solforato (H2S) (odore di uova marce) e dimetilsolfuro sono tipiche di impianti di depurazione, smaltimento rifiuti e di processi industriali. L’H2S a basse dosi provoca disagio olfattivo, ma a concentrazioni elevate diventa acutamente tossico, inibendo addirittura la percezione dell’odore e potendo indurre perdita di coscienza o danni sistemici paragonabili a sostanze estremamente velenose.
Composti organici volatili (COV)
Tra questi spiccano benzene, toluene e xilene, comunemente associati a odori di carburanti, solventi e vernici. Il benzene, in particolare, è una sostanza cancerogena riconosciuta e rappresenta un rischio anche a basse esposizioni prolungate. Altri VOC tipici degli ambienti interni derivano da deodoranti, detergenti e profumazioni ambientali.
Ammine, mercaptani e acidi grassi volatili
Odori come quelli di pesce avariato (ammine), cipolla marcia (etilmercaptano), burro rancido (acido butirrico), aceto (acido acetico) e sudore (acido valerico) sono prodotti dalla decomposizione di materia organica animale o vegetale. Anche se non sempre sono un pericolo diretto alla concentrazione percepibile dal naso umano, la loro presenza indica processi putrefattivi e inquinamento microbiologico, oltre a causare reazioni irritative respiratorie e mucose in soggetti vulnerabili.
Smog e odori urbani
Il classico odore acre delle aree urbane densamente trafficate è il risultato della combinazione tra ossidi di azoto, anidride solforosa, composti carboniosi e particolato. Esporsi a questi odori significa inalare contemporaneamente sostanze la cui pericolosità sulla salute pubblica è ben documentata, in particolare per l’apparato respiratorio e cardiovascolare. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, milioni di decessi annuali sono attribuibili direttamente agli inquinanti atmosferici correlati a questi odori.
Profumi e fragranze: rischi spesso sottovalutati
Un capitolo a parte meritano i cosiddetti odori gradevoli prodotti artificialmente, come quelli presenti in profumi, deodoranti, detersivi e prodotti cosmetici. Questi contengono spesso miscele complesse di COV e altri additivi chimici.
Secondo numerosi studi medico-scientifici, soggetti con asma, allergie, riniti, sinusiti, malattie croniche dell’apparato respiratorio o predisposti a dermatiti, possono manifestare peggioramenti significativi dei propri sintomi già a basse esposizioni ai profumi comuni. I disturbi più frequenti includono cefalee, irritazioni cutanee o delle mucose respiratorie, crisi asmatiche e sensazione di malessere (“mal d’ambiente”).
La presenza di fragranze sintetiche nell’ambiente chiuso può inoltre abbassare la qualità dell’aria indoor, rappresentando un rischio concreto per lavoratori, studenti e individui particolarmente sensibili. Ciò riguarda, tra l’altro, la cosiddetta “sensibilità chimica multipla”, una condizione caratterizzata da reazioni avverse a bassissimi livelli di inquinanti ambientali e odori artificiali.
L’inquinamento olfattivo e salute collettiva
L’“inquinamento olfattivo” non si limita all’effetto nocivo di una singola sostanza, ma considera la commistione di molte molecole, spesso presenti insieme in quantità variabili, che rendono difficile stabilire una soglia universale di rischio. Il disagio per la popolazione può essere sia diretto (mal di testa, nausea, irritazione agli occhi e alla gola, difficoltà respiratoria) sia indiretto: alterazione del sonno, aumento dello stress cronico, disturbi dell’umore e sociale.
Alcuni dei principali settori fonte di emissioni odorigene rilevanti sono:
Anche nei contesti rurali possono risultare problematici gli odori legati ad attività agricole intensive, fertilizzanti e stabulazione animale. Uno degli effetti indiretti più rilevanti di questa tipologia di inquinamento riguarda la qualità della vita e la salute psicofisica della popolazione residente, spesso impossibilitata a difendersi da esposizioni involontarie e prolungate.
Odori come segnale “sentinella” di pericolo
Il ruolo dell’olfatto nella difesa individuale è essenziale: percepire una puzza improvvisa o persistente rappresenta spesso un meccanismo di allarme, poiché molte delle sostanze tossiche più pericolose per l’uomo hanno odori molto facilmente riconoscibili. Questo vale per l’idrogeno solforato, per il gas metano addizionato di mercaptani (il caratteristico odore di “gas”), per il benzene o per l’acridità tipica dello smog urbano.
Tuttavia, esistono anche numerose sostanze tossiche inodori o che a concentrazioni elevate “anestetizzano” l’olfatto stesso, costituendo così una doppia minaccia perché la percezione diventa inefficace come sistema di allerta: è il caso, ad esempio, dell’idrogeno solforato o del monossido di carbonio, un gas inodore ma letale.
Inoltre, la percezione di odori molesti e la prolungata esposizione ad essi sono oggi riconosciute come parametri di valutazione ambientale in molte città e regioni, così da regolamentare e limitare sistematicamente le emissioni dannose, sia per tutelare la salute collettiva sia per proteggere l’ecosistema, i terreni e le acque da una contaminazione diffusa.
In conclusione
I rischi correlati agli odori dipendono dal tipo e dalla concentrazione delle sostanze presenti, con implicazioni che vanno dal semplice fastidio alla comprovata tossicità acuta o cronica. Prendere consapevolezza, saper riconoscere e segnalare la presenza di odori insoliti o persistenti è dunque un aspetto fondamentale di prevenzione sociale e sanitaria, integrando gli odori non solo tra i parametri di vivibilità urbana ma anche tra gli indicatori precoci di inquinamento e rischio per la salute.